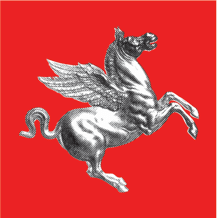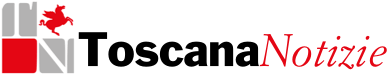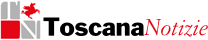Un anno e mezzo prima della marcia su Roma, la casa della cultura slovena a Trieste – Narodni Dom – fu data alle fiamme. Era il 13 luglio 1920, l'edificio ospitava abitazioni e associazioni della comunità slovena e lì si concentrava la vita economica, politica, culturale, artistica e sociale della minoranza slava, molto attiva agli inizi del Novecento in città.
Fu il battesimo dello squadrismo fascista organizzato. Ed è lì, guidati dallo storico Stefan Cok, che la comitiva toscana del pellegrinaggio della memoria inizia un nuovo viaggio, quello nella Trieste multiculturale, con le sue memorie (al plurale) lungo tutto il Novecento, dal solido e multietnico impero austro-ungarico che si scioglie come neve al sole alla dissoluzione della ex Jugoslavia, una trentina di anni fa: italiani, sloveni, tedeschi, ebrei, armeni, greci… fascisti, nazisti, liberali, socialisti, comunisti. Da porto di un grande impero a porto residuale dell’Italia repubblica a cortina di ferro tra Usa e Urss. Un confine ‘difficile’ e mobile, come spesso è stato raccontato, in una città in cui ci si poteva dividere a destra, tra liberali e fascisti, ma anchea sinistra, tra comunisti italiani e comunisti sloveni. Una città che nella primavera del 1945 diventa il teatro della "corsa per Trieste" tra gli jugoslavi di Tito e gli alleati che si giocano sul filo dei giorni la Liberazione dal Reich nazista che volle e utilizzò l'unico campo di sterminio nazista presente in Italia, la Risiera di San Sabba. Arriveranno prima i titini e per un mese - finché non saranno sostituiti dagli angloamericani - si vive nei boschi intorno alla città il terrore dei processi sommari e delle foibe in cui verranno gettati i corpi di qualche centinaio di persone, perlopiù italiane ma anche slave che si opponevano al regime comunista. Una città dove sotto i piedi si srotolano, anche, oltre centocinquanta pietre d’inciampo, a ricordo di chi fu arrestato e deportato.
Il racconto di Cok si srotola proprio a partire da quel pomeriggio d’estate del 13 luglio 1920, quando il segretario cittadino del Partito fascista, il fiorentino Francesco Giunta, convocò un comizio dopo l'uccisione di due militari italiani a Spalato. Giunta affermò che "era l'ora di agire". La folla da Piazza dell'Unità agì: si spostò sotto il Narodni Dom e iniziò ad assediarlo da ogni lato, circondato da soldati, carabinieri e guardie che cercavano di mantenere l'ordine. Durante gli scontri che portarono al ferimento di otto persone e all'uccisione di un carabiniere, gruppi di fascisti forzarono le porte dell'edificio, vi gettarono all'interno alcune taniche di benzina a cui diedero fuoco, dopodiché impedirono ai pompieri di spegnere l'incendio. Il farmacista Hugo Roblek morì, gli altri ospiti riuscirono tutti a salvarsi. Le fiamme furono domate completamente solo il giorno successivo, ma ormai l'edificio era distrutto.